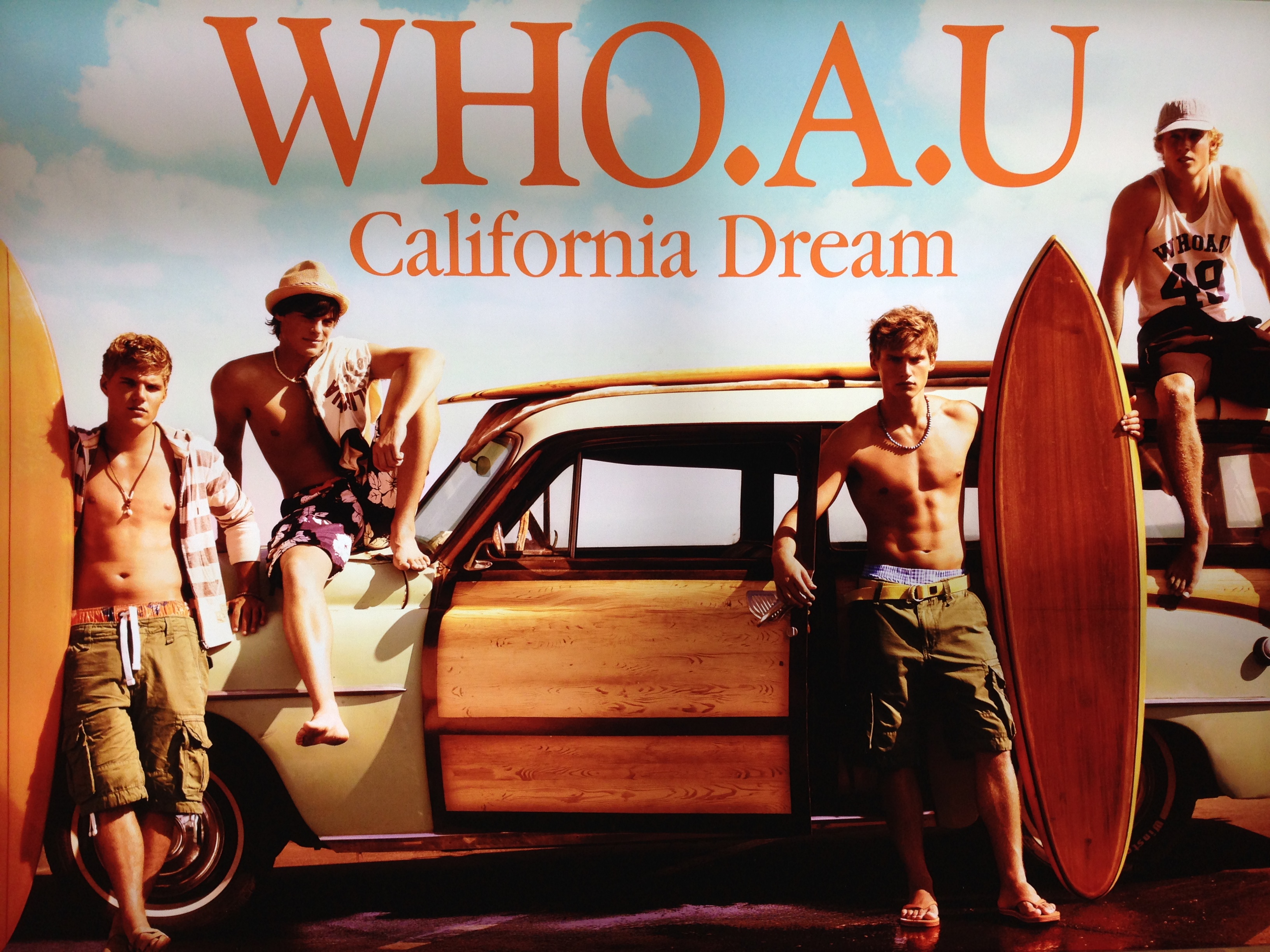Esiste un culto antico, un culto che rappresenta il vero substrato della spiritualità dei cinesi, che ha poi in parte accolto ed è stato accolto dal taoismo, dal confucianesimo e dal buddhismo. Senza questo manca qualcosa alla spiritualità cinese, qualcosa di semplice, ordinario ma anche di molto profondo.
Qualcosa che spesso non può essere individuato ma è sempre stato lì dal tempo in cui Pan Gu ha separato il Cielo e la Terra e prima che Nuwa creasse gli uomini.
È trasparente e incolore come l’aria e per questo viene scambiato con le varie forme e i vari colori con cui entra in contatto.
Questo culto, che molte volte è associato al taoismo, è in realtà più antico anche di questo: è la religlione popolare dei cinesi.
È la manifestazione shen (神) delle forze del cielo della terra e dell’uomo. L’anima ling (靈) del mondo. Il respiro primordiale qi (氣) dell’universo, di tutto ciò che esiste e non esiste.
Molte di queste tradizioni e miti sono stati raccolti nel “Classico dei Mari e delle Montagne”, lo Shan Hai Jing, un testo che risale a più di duemila anni fa e che originariamente fu attribuito al primo sovrano leggendario della dinastia Xia, colui che controllò la grande alluvione: Yu il Grande.
La prima volta che sono entrato in questo mondo era da bambino, nei miei primi viaggi tra le comunità cinesi del sud-est asiatico.
Sono sempre stato affascinato da questa dimensione e da quelle che apparivano come le sue regole ma che in realtà erano solo i ritmi del suo fluire. Ritmi che intuitivamente mi sembrava di conoscere, di aver già conosciuto e che per me erano come un gioco.
Ero così attratto da quei volti austeri, da quelle figure rosse e nere coperte di ornamenti, i loro sguardi, a volte compassionevoli e a volte feroci, mi guardavano nel silenzio degli spazi sacri, dietro al fumo degli altari.
Mi rassicuravano, sentivo la loro protezione e ho sempre stretto amicizia con loro, quell’amicizia sincera e curiosa che conoscono solo i bambini.
“Ciao io mi chiamo Andrea, voi come vi chiamate? Chi siete? Che fate qui? Perché siete così? Perché avete quegli oggetti in mano?”
E a quelli dai volti più feroci:”Siete brutti ma buoni?”
Un amicizia che non voleva qualcosa in cambio, in cui c’era sempre un timoroso rispetto come quello che i bambini danno a un adulto o a un anziano.
Erano tanti i giochi a cui giocare: il gioco dell’accendere le candele, del bruciare incensi e la carta colorata, il gioco del pescare le asticelle di bambù con i responsi, il gioco dei talismani protettivi, il gioco delle benedizioni e alla fine il gioco del portarsi il libretto illustrato a casa che per me era come un fumetto, un fumetto di cui non riuscivo a leggere la lingua ma che mi facevo raccontare dai saggi associando il racconto alle figure.
Ho mantenuto questo approccio alla spiritualità anche negli anni successivi. Infatti l’unico modo che aveva mio nonno di portarmi in chiesa era quello di comprarmi Topolino che io leggevo in silenzio aspettando di cantare l’alleluia, di fare l’offerta alla vecchietta che passava tra le panche con la scatola e di scambiarmi il segno di pace con gli altri intorno a me. Queste per me erano le parti migliori, quelle che avevano più significato. Avrei volentieri giocato anche alla comunione ma mi dicevano che non potevo.
Il resto, le ripetizioni e le prediche erano di una noia incredibile ma io avevo il testo sacro della Disney a illuminarmi la strada.
Una volta a cinque-sei anni, guardando le statue dei santi nella chiesa di Ponte Milvio, domandai sempre a mio nonno perché non c’erano quelle di Biancaneve e dei sette nani che andavo a trovare ai giardinetti accanto alla Chiesa della Madonna dell’Olmo o alla stazione dei treni Gualdo Tadino. Certo che con quella domanda devo averlo proprio messo alla prova.
Insomma nella vita ho sempre giocato, ho imparato giocando e continuo a giocare imparando. Anche i miei primi libri sono stati i librogame.
Alcuni hanno giudicato questo comportamento come superficiale e sono riusciti quasi a farmi credere che fosse vero, che forse avevano ragione loro. In un mondo serio di adulti, esperti e studiosi infatti si deve essere seri, non c’è più spazio per il gioco e sembra essercene sempre meno per la gioia.
Dopotutto quando sono in tanti a pensarla in un modo e tu sei uno, ti vengono dei dubbi: forse la vita è serietà, la vita è sacrificio. Dovrei soffrire di più? Forse avevano ragione a scuola quando dicevano che ridevo troppo? Dovrei ridere meno, essere meno felice, piangere di più?
“Andare più in profondità” nelle cose rinchiudendomi nelle biblioteche, nella cassaforte della filosofia, dell’ideologia e dell’intellettualismo? E poi contrarre i muscoli del volto in espressioni accigliate, schiarendomi la voce prima di parlare in un tono grave e pieno d’orgoglio?
Questo forse piacerebbe di più perché rientrerebbe in quello che la società vede come qualità del buon cittadino, della “persona colta”, una persona prigioniera di modelli comunemente accettati come “giusti”, “dotti” e “saggi”.
(Forse l’avete già scoperto che per me Dotto è solo uno dei sette nani).
No! Finalmente ho capito che non avevano ragione gli altri. La mia non era superficialità ma leggerezza, non era stupidità ma semplicità, gioia, senso dell’umorismo e curiosità verso la vita, qualità che mi hanno fatto sempre innalzare sopra la sofferenza e volare alto sul mondo. Qualità che sono state preziose e indispensabili nella mia vita e che mi hanno sempre fatto rinascere dalle mie ceneri.
Ma dare ragione a me a questo punto potrebbe essere molto più complicato per questi altri, significherebbe rimettere in discussione le loro idee, i loro valori con le lettere maiuscole, la loro visione della vita.
Mi dispiace, continuerò ad andare per la mia strada nonostante tutti i loro “buoni” consigli.
Non ho mai veramente seguito e mai seguirò nessuna -gia, nessuna -fia, nessun -ismo e nessun -esimo. Seguo solo il mio cuore e intuitivamente so di non sbagliare.
A una cosa mi sto avvicinando sempre di più e cioè che se non si è veramente se stessi, se non ci si libera di tutte le maschere e i falsi ruoli che ci sono stati imposti e se non si sta facendo quello che si desidera veramente nella vita, non si può essere felici.
Queste sono parole che abbiamo sentito tante volte e che spesso abbiamo ripetuto come dei pappagalli a noi stessi e agli altri ma che, nella maggior parte dei casi, non abbiamo compreso profondamente, non abbiamo realizzato.
Qualcuno potrebbe obbiettare che per molte religioni la vita è sofferenza, anche la prima Nobile Verità del Buddha dice così (cioè che tutto alla fine ci porterà a sofferenza e insoddisfazione) e potrebbe usare questo come giustificazione per continuare a vivere nella propria infelicità e a mantenere un atteggiamento triste e rassegnato.
L’infelicità non sempre è manifesta o non sempre ne siamo completamente consapevoli. Spesso è sottile, si nasconde dietro a una falsa euforia, a falsi sorrisi, alla macchina nuova, alla casa nuova, alla cena in un ristorante chic, all’uso compulsivo di internet, di una chat o di un social network.
Una ricerca che ci porta ad una continua corsa al piacere e all’acquisizione ma che però finisce solo per creare nuovi legami e costrizioni, nuove paure e nuove sofferenze.
Ma il Buddha vede che tutto è uno show, un teatrino di marionette e per questo ride. L’insegnamento sta nel ridere come lui ed essere felici anche nelle avversità.
O se preferite Battiato trovare l’alba dentro all’imbrunire o un centro di gravità permanente.
Un’altra bella immagine di questo è data anche dalla canzone il Cielo è sempre più blu di Rino Gaetano.
Ci sono dei nodi che sembrano indissolubili ma in realtà basta tirare leggermente la corda per scoprire che non erano mai esistiti.
Una cosa è certa: se non si ride più e si è perso il senso dell’umorismo o se si ride poco, vuol dire che qualcosa non va, che i filosofi che abbiamo studiato non ci sono serviti e che siamo molto lontani dalla felicità e dalla saggezza. Perché un saggio che non sa ridere è solo uno stolto.
Questa è la società che vorrebbe che mettessi “la testa a posto” ma per fortuna non l’ho messa altrimenti mi ci avrebbe dato un sacco di mazzate come i carabinieri a Pulcinella.
Impone le sue regole come faceva lo sceriffo di Nottingam ma io sono Robin Hood o, come la Compagnia delle Indie, cerca la mia fedeltà tentando di farmi stipulare un trattato ineguale per impossessarsi del mio regno ma io sono la Tigre di Mompracem.
Vorrebbe quadrarmi ma sono tondo, vorrebbe che fossi un sasso piatto che giace in fondo a un lago ma sono un rolling stone che rotola lungo una vasta pianura. Dopotutto non si può dire che sono uno che quando cammina riga dritto (quelli che mi conoscono lo sanno).
In questo gioco di ombre e di luci, non sono ancora stato preso ma forse riesco a fare tana libera tutti così le regole del prossimo gioco le decideremo noi.
Non sono andato fuori tema, è che partendo da un saggio sulla spiritualità dei cinesi sono nate nuove riflessioni così ho pensato di seguire l’ispirazione e condividerle con gli altri. Se me le fossi tenute per me infatti sarebbero servite a poco e si sarebbero seccate come fiori in inverno.
In fare questo mi sento più umano e spero di essere riuscito a farvi sentire più umani anche a voi o almeno a regalarvi un sorriso ma quando un giorno riusciremo a ridere della vita, di noi stessi e dei nostri problemi, di goderci il nostro teatrino come il Buddha, allora quella sarà la cosa più bella.
Quando questo accadrà tutta la tensione, le paure, e i pensieri si scioglieranno nell’aria in un istante, cadrà una bellissima pioggia, i primi raggi di sole cominceranno a farsi strada tra le nuvole e comparirà l’arcobaleno.